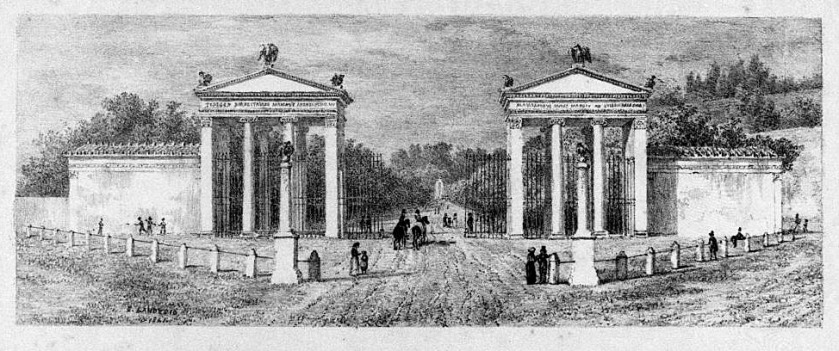Quella che segue è una riflessione scritta più di un anno fa e circolata in forma privata solo tra le mie amiche “ex museali”. E già allora, come è possibile intuire, c’erano badilate di conati di vomito sedati da conversazioni antiemetiche che hanno tamponato questo stato di diffuso malessere, equamente distribuito, ma non annacquato.
Poi, qualche giorno fa ho dovuto ascoltare delle parole che mi hanno fatto correre nelle latrine della vergogna a rigurgitare il mio sdegno.
Oggi è il 5 dicembre di un anno che politicamente ha fatto abbastanza schifo e che dopo i risultati referendari non credo si concluderà tanto meglio. Il mio giudizio è stato quello della maggioranza dei votanti, ma non per questo non temo il domani. Pubblicare queste righe è per me una medicina. O semplicemente un, ancor di più mendace, placebo.
“La mia amica mi inoltra la newsletter del MAXXI, newsletter che con ovvi toni sensazionalistici e accattivanti dichiara che Enel diventa il socio a braccetto del Museo di via Guido Reni. Scorro il testo che mi allega e, sì, c’è proprio scritto che “Enel aderisce alla Fondazione MAXXI ed è il primo privato a divenire socio fondatore del museo, inaugurato nel 2010 e gestito da una Fondazione di diritto privato istituita nel 2009 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ne è socio fondatore-promotore.” Di seguito si sciorinano gli evidenti benefici della joint venture: collezione gratis per tutti (ma solo dal martedì al venerdì), abbattimento del 40% dei costi delle luci (Artribune riporta il 50%), realizzato grazie all’utilizzo del LED e alle minori spese di manutenzione e, infine (ma a me sembra già abbastanza lunga sta pippa) consistenti proventi per le attività espositive.
Artribune mostra le stesse sfumature entusiastiche, confermando la presenza di Elisa e Cracco al prossimo “Acquisition Gala Dinner” aggiungendo: “Finalmente il museo si affranca dal suo discutibile catering interno. Che sia un viatico per una ristorazione all’altezza?”
Ecco, da dove vogliamo partire? Qual è la parte più aberrante di tutte queste (vuote) parole? Una su tutte è che l’Enel si fregia di essere innovativa e stare sul pezzo del risparmio energetico. Ma non dovrebbe essere prassi per un’azienda che si occupa di questo? Il risparmio, poi, lo garantisce solo perché partner di una struttura e quindi risvolto positivo e elitario in funzione di una scelta del genere? Non dovrebbe essere una politica da adottare sempre e per tutte le utenze, visto che una migliore ed efficiente distribuzione di energia garantisce risparmi considerevoli e condivisibili?
Nel caso del museo si spera possa portare anche a una diminuzione del biglietto d’ingresso, che trovo economicamente pompato rispetto a un’offerta di dubbia qualità. Meno male che la collezione è gratis! Ma perché è gratis? Perché qualche eminenza grigia s’è destata e ha scoperto che il MAXXI durante i giorni feriali è occupato solo dai guardasala e dalle balle di fieno rotolanti?
Di cultura ne abbiamo bisogno. Non mi voglio riempire la bocca di frasi fatte o scontate, ma ne abbiamo bisogno perché la vogliamo, la desideriamo e la aspettiamo. Sì, la aspettiamo. Le prime domeniche del mese i musei statali e comunali si riempiono di persone che come me aspettano più o meno diligentemente di visitare spazi convenzionalmente a pagamento. Questo non è un bisogno? Bisogno di crescere, bisogno di nutrirsi, bisogno di imparare. E tutto questo necessita dei Cracco e delle Elise? Non ho niente contro di loro (sto mentendo: Cracco riesce ad essermi ancora più indigesto delle patatine che sponsorizza e con le quali ha combinato inenarrabili schifezze. Elisa, invece, la adoro; mi ha tenuta per mano in tante situazioni importanti e passaggi di vita che m’hanno fatto diventare l’essere sconclusionato che sono), ma non reputo sia un museo, soprattutto durante una acquisitiongaladinner, che non è nient’altro che una raccolta fondi – o crowfunding se vogliamo utilizzare per forza una parola straniera tanto in voga in questi anni – il loro posto. E non perché non valgano, ci mancherebbe. Questo è intrattenimento, puro e semplice intrattenimento. Trovo sacrosante le attività ludiche negli spazi espositivi, ma che siano affini alle opere presentate. In un momento di richiesta di aiuto (perché il crowfunding è essenzialmente questo, un’azione partecipativa dal basso per sopperire alle mancanze dall’alto) si dovrebbero presentare progetti, intavolare discussioni, rendere nota la destinazione dei fondi, e noti, con nomi e cognomi, coloro che materialmente li gestiranno. Se penso a quello che sto scrivendo mi sento un po’ complottista, ma temo che dietro tutto questo ambaradan ci sia solo una fumosa e stordente fuffa. Insomma, ce la stanno incartando, ci stanno raccontando che è tutto molto figo, ma non ci stanno dicendo il perché. Tutto rimane in superficie, tra una ballata e uno spaghetto alle vongole (che, mi raccomando, sia di ottima qualità perché, si sa, al museo ci si va per mangiare sopraffino e dire urbi et orbi di averlo fatto), vorrei capire cosa resta. Non credo sia necessario essere delle storiche e storici dell’arte per formulare il pensiero, sicuramente epidermico e senza grandi prospettive, come questo che ho appena fermato. Reputo, invece, sia fondamentale una minima dose di criticità per leggere tra le righe e saper mescolare, con lucidità e autonomia, opinioni e punti di vista differenti per produrre una personale linfa mentale. E l’arte, se è vera e onesta, aiuta anche a far questo. Stimola la capacità di osservazione e induce alla riflessione. Ci fornisce la valigia dove conservare i nostri valori e con questi smascherare le bufale che i furbetti di turno vogliono somministrarci, magari accompagnate con ottimo pane di Kamut, che non è nient’altro che un marchio registrato e costoso per indicare il grano khorasan…”
Potrei scegliere tra tante immagini quella più adatta per questo post, ma non voglio immagini, non voglio opere d’arte e non voglio bellezze. La loro assenza ha per me il significato di una piccola, forse inutile, forma intima di protesta.